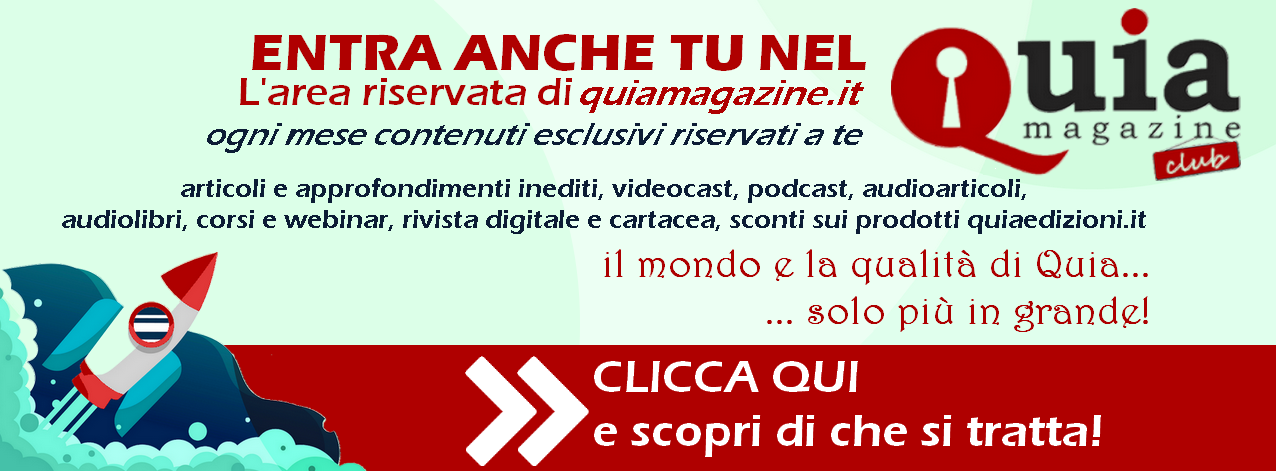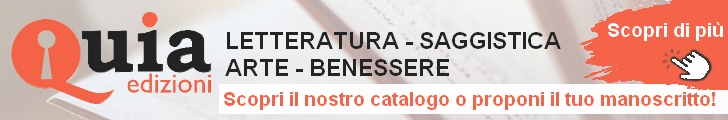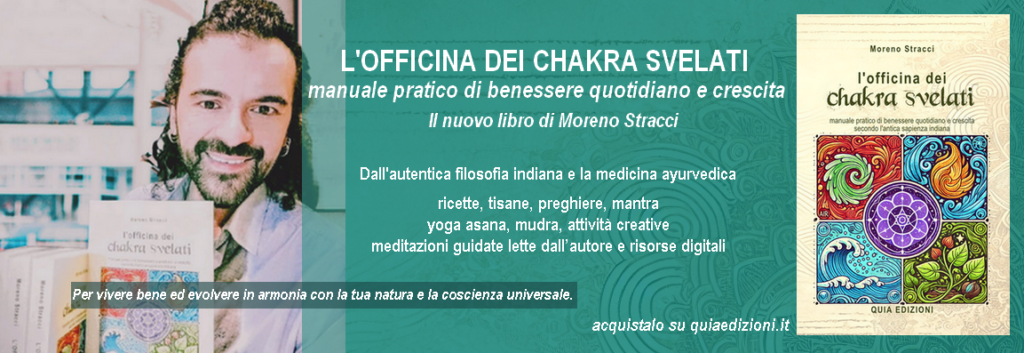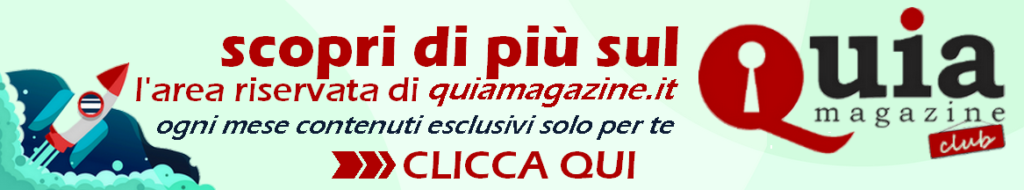25 aprile 2025: ottant’anni dalla Liberazione. Ma perché si torna a parlare di fascismo?

di Pamela Stracci
Sono passati ottant’anni da quel 25 aprile 1945, giorno della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, della fine dell’occupazione tedesca e della caduta della Repubblica Sociale Italiana. Un giorno scolpito nella storia repubblicana, eppure oggi, nel 2025, più che mai sembra necessario chiedersi: perché si torna a parlare di fascismo? Cosa abbiamo dimenticato?
La memoria che sfuma
I protagonisti della Resistenza e della guerra sono quasi tutti scomparsi. Con loro se ne sono andati i testimoni diretti, i ricordi vividi, le cicatrici mai guarite. Restano le immagini d’archivio, i documenti, i libri — ma per molti giovani e giovanissimi il fascismo è un nome nei manuali, un’ombra indistinta o peggio qualcosa da riesumare per avere rispetto e prestigio. Le generazioni dei nipoti e pronipoti di chi combatté per la libertà non hanno più il racconto in casa. E se la scuola non colma quel vuoto – non si arriva mai e dico mai a svolgere il programma scolastico relativo alla Seconda Guerra Mondiale – se la società tace o mistifica, allora la memoria collettiva si fa fragile e gli incubi ritornano da passato.
Sono stata fortunata, lo ammetto, perché la mia educazione ha viaggiato su un esempio forte nella mia famiglia, un esempio che custodisco gelosamente come un tesoro nonostante sono passati 45 anni dalla sua morte: mio nonno Pietro Frezza che negli anni della guerra era solo un giovane carabiniere quando dovette affrontare – insieme ai suoi compagni – la ferocia nazifascista e la deportazione. Qual è il vostro esempio?

Quando la libertà diventa scontata
Il fascismo certo non torna con le stesse camicie nere, gli stessi slogan, gli stessi saluti (o forse si?!). Torna nel disinteresse, nell’indifferenza, nella mancata espressione del diritto di voto, nella sfiducia verso la democrazia. Torna ogni volta che si minimizzano le leggi razziali, che si tollerano linguaggi autoritari, che si confondono libertà e odio, che si accettano per buoni messaggi populisti tesi a dividere i cittadini. Torna ogni volta che si dimentica che quella libertà — oggi data per scontata — fu conquistata col sangue, con la clandestinità, con la scelta dolorosa di chi si oppose, anche da solo.
Perché non bisogna incoraggiare al neofascismo
Perché il fascismo fu negazione della libertà, persecuzione, guerra, violenza di Stato, repressione del dissenso. Perché mise al bando partiti, sindacati, idee. Perché tolse parola e dignità a intere generazioni. Perché ridusse l’Italia a un Paese vassallo, complice dell’Olocausto, corresponsabile delle rovine morali ed economiche del continente.
Non bisogna pensare al fascismo come un ritorno ineluttabile e necessario per dare all’Italia quel prestigio che sicuramente tutti desideriamo per la nostra nazione, perché l’autoritarismo, ieri come oggi, si nutre di ignoranza e paura e genera solo prepotenza e violenza. E perché in un mondo attraversato da nuove crisi — guerre, disuguaglianze, emergenze ambientali — ma anche da diverse evoluzioni delle esigenze dei cittadini, la democrazia è la sola che ancora può offrire risposte condivise, inclusive, e soprattutto pacifiche per una società dove – attenzione! – è labile il confine del diventare “l’altro”, il diverso, il nemico.
È un dovere di tutti, elettori di destra e di sinistra, tutelare la libertà opponendola come un distintivo d’onore a tutte quelle persone che vorrebbero riportare in auge quegli ideali dispotici che non appartengono più al nostro tempo.
Chi ha portato alla Liberazione?
Il processo di Liberazione non è stato opera solo di alcuni gruppi o alcune persone nè esclusivamente ad opera degli Alleati. La potenza militare degli Alleati fu indispensabile certo per sconfiggere le forze nazi-fasciste sul campo di battaglia. La Resistenza Italiana invece è stata costituita sia dai partigiani, che da singole persone (sia di destra che di sinistra perchè la libertà e la giustizia non hanno colore politico!) che hanno rischiato la vita per proteggere i più deboli. Poi c’è l’Arma dei Carabinieri, custode dell’ordine pubblico e promotore di giustizia, che si fece apripista alle formazioni partigiane, fornendo servizi di sicurezza, rifornimenti e comunicazioni e proteggendo il popolo.
Leggi l’approfondimento: Carabinieri contro il Fascismo: Un Giuramento di Libertà
Il Papa, i festeggiamenti “sobri” e “i dolori della guerra”
Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci ha confermato che per la ricorrenza della Liberazione di quest’anno, coincidente con i 5 giorni di lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, “Tutte le cerimonie sono consentite naturalmente, tenuto conto del contesto e quindi con la sobrietà che la circostanza impone a ciascuno”.
In molti hanno visto la chiesta sobrietà come una “scusa” del Governo per limitare la manifestazione che certo non è proprio nelle loro corde.
Ma Papa Francesco cosa avrebbe detto a tal proposito? Sobrietà o manifestazione?
Certo adesso non può risponderci direttamente ma possiamo intuirlo con le parole che lui stesso ha detto e che sono state riportate su un articolo pubblicato da Famiglia Cristiana nel 2018 in risposta alla domanda di Fiorella Bacherini.
Questa nonna di 83 anni chiede al Papa “…Non voglio discutere di politica, parlo dell’umanità. Com’è facile far crescere l’odio tra la gente! E mi vengono in mente i momenti e i ricordi di guerra che ho vissuto da bambina. Con quali sentimenti Lei sta affrontando questo momento difficile della storia del mondo?”
E il Papa risponde così: “I giovani non hanno l’esperienza delle due guerre. Io ho imparato da mio nonno che ha fatto la prima, sul Piave, ho imparato tante cose, dal suo racconto. Anche le canzoni un po’ ironiche contro il re e la regina, tutto questo ho imparato. I dolori, i dolori della guerra… Cosa lascia una guerra? Milioni di morti, nella grande strage. Poi è venuta la seconda, e questa l’ho conosciuta a Buenos Aires con tanti migranti che sono arrivati: tanti, tanti, tanti, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Italiani, polacchi, tedeschi… tanti, tanti. E ascoltando loro ho capito, tutti capivamo cos’era una guerra, che da noi non si conosceva. Credo che sia importante che i giovani conoscano gli effetti delle due guerre del secolo scorso: è un tesoro, negativo, ma un tesoro per trasmettere, per creare delle coscienze…”
Il valore del 25 aprile, oggi
Celebrare questa ricorrenza, dunque, non è solo un rito del passato. È un atto politico, nel senso più alto del termine: significa scegliere da che parte stare, ogni giorno. Significa insegnare ai giovani che la libertà è un bene fragile, che non c’è giustizia senza memoria, che il futuro si costruisce solo conoscendo ciò che è stato e solo rispettando l’altro.
E allora, in questo 25 aprile 2025, non chiediamoci soltanto cosa festeggiamo, ma chi vogliamo essere. Perché se oggi possiamo votare, dissentire, manifestare ma anche essere eccentrici e dire la nostra sui social, è grazie a chi, ottant’anni fa, scelse la strada più difficile, ma anche la più giusta: quella della libertà.
© Riproduzione riservata