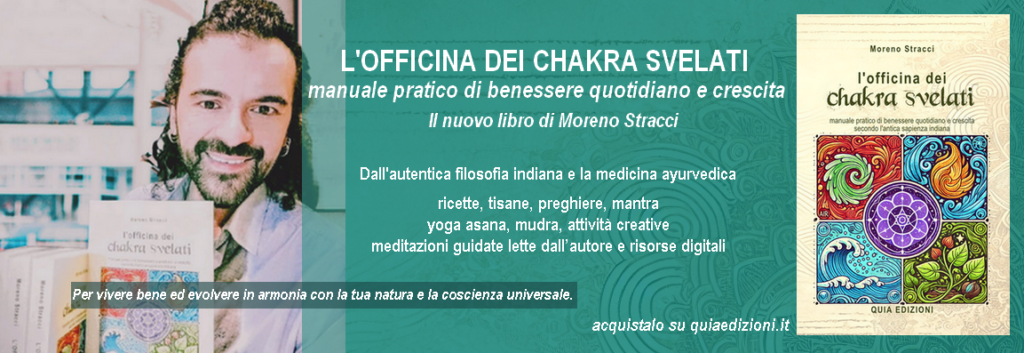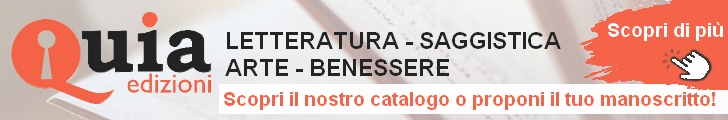Referendum dell’8 e 9 giugno: l’Italia al bivio tra voto e astensione. Il social experiment svela un Paese diviso e agguerrito

di Pamela Stracci
A pochi giorni dal referendum dell’8 e 9 giugno, che vedrà gli italiani chiamati alle urne su diversi quesiti, il dibattito tra l’esercizio del voto e la scelta dell’astensione si accende, soprattutto sui social media. Per cogliere il sentire “a caldo” dei cittadini, abbiamo condotto un esperimento sociale su Facebook, cercando di superare la rigidità dei sondaggi tradizionali. L’obiettivo: dare voce al popolo della rete, in modo libero e spontaneo.
Il Metodo: un commento, due scenari
Il nostro approccio è stato diretto: un giornalista della nostra testata ha inserito un commento su post di due tra i più noti quotidiani nazionali su Facebook, invitando genericamente al voto come espressione della sovranità popolare, senza esprimere preferenze sul “sì” o sul “no” nè a favore di alcun partito politico.
Il primo scenario si è aperto sotto un post che trattava di “Come cambiano le regole sulla Cannabis light ora che il decreto sicurezza è legge”. Molti utenti si sono scatenati contro la nuova normativa. Il nostro commento, che invitava a votare per far sentire la voce del popolo, ha raccolto solo 18 “like” e una singola risposta, a fronte dei 684 “like” del post originale. Un segnale di scarsa risonanza sul tema del voto in un contesto di dibattito specifico.
Il secondo scenario ha avuto un esito ben diverso. Il post di un altro quotidiano riportava una dichiarazione della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Ai seggi per rispetto ma l’astensione è un diritto”. Qui, il nostro commento, sempre improntato all’invito al voto come segno di “presenza popolare alla vita dello Stato”, ha scatenato un’ondata di reazioni ben maggiore.
I Risultati: una partecipazione polarizzata
I dati raccolti sul secondo post sono stati significativi. Su poco più di mille reazioni al post originale (quando è stato chiuso il social experiment), il nostro commento ha ricevuto ben 447 reazioni e 117 risposte.
Analizzando il profilo demografico dei commentatori, abbiamo registrato 30 uomini e 23 donne. Tra questi, 22 persone si sono espresse a favore del voto, mentre una netta maggioranza, 31 individui, ha manifestato una preferenza per l’astensione.
Particolarmente rivelatore è stato il tono dei commenti: circa il 90% degli utenti intenzionati ad astenersi ha mostrato un comportamento agguerrito, arrivando persino a insultare il nostro giornalista, percepito come un qualunque utente social. Al contrario, solo il 10% di chi ha dichiarato di voler votare ha mantenuto un atteggiamento poco cordiale verso chi ha espresso il “diritto” all’astensionismo. Questo suggerisce una polarizzazione emotiva più marcata tra i sostenitori dell’astensione.
Cosa Dicono gli Italiani: “Non votare è lecito”
La motivazione più ricorrente tra gli utenti social che propongono l’astensionismo è la questione che non votare sia lecito e costituisca comunque una forma di voto.
Su questo punto, è fondamentale fare chiarezza. L’articolo 48, secondo comma, della Costituzione italiana definisce il voto un «dovere civico». Questa formula è il risultato di un compromesso storico tra chi voleva l’obbligatorietà del voto con relative sanzioni e chi si opponeva a tale vincolo.
La natura giuridica del “dovere civico” è stata definitivamente chiarita nel 1993. Due articoli del “Testo unico sulle leggi elettorali” (D.P.R. n. 361 del 1957), che originariamente sancivano il voto come un “obbligo” e prevedevano sanzioni per chi si asteneva, sono stati abrogati. Oggi, l’articolo 4 del Testo unico si limita a proclamare che «il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica». Dunque, votare è un dovere civico, ma non un obbligo giuridicamente vincolante e sanzionabile. Non votare è, pertanto, lecito.
Nonostante ciò, la Corte Costituzionale, già nel 1968, ha ribadito il «carattere universale» del dovere civico di votare, estendendolo a ogni tipo di consultazione, sia politica che referendaria, e non solo agli organi elettivi.
È importante sottolineare che la legge non contempla l’astensione come un’alternativa esplicita al voto o al “non-voto”. Nelle normative sui referendum abrogativi, per esempio, si definiscono solo le conseguenze della prevalenza dei “Sì” o dei “No”. Giuridicamente, l’astensione non è equiparabile al voto contrario, sebbene sul piano pratico possa produrre un risultato simile. Questa distinzione è cruciale: equiparare il “non-voto” al voto negativo significherebbe attribuire un messaggio politico anche a chi si è astenuto per disinteresse, pigrizia o impossibilità, non per una scelta consapevole.
Quindi non andare a votare è lecito, ma è votare che è un diritto!
Il Quorum e il Quesito sulla Cittadinanza: le vere paure
Tra le principali preoccupazioni di chi intende astenersi, emerge con forza la strategia di non far raggiungere il quorum per evitare la validità del referendum. L’attenzione è focalizzata in particolare sul quesito n. 5, che propone la riduzione dei tempi per richiedere la cittadinanza italiana (da 10 a 5 anni di residenza legale, senza alterare gli altri requisiti).
Dietro questa posizione si cela il timore che una concessione più rapida della cittadinanza a chi non è italiano possa portare a un collasso dello stato sociale, con ricadute negative su settori chiave come le future pensioni e l’assistenza sanitaria.
Per chiarezza, i requisiti attuali per la cittadinanza italiana si basano principalmente sullo “ius sanguinis” (diritto di sangue). Tuttavia, i cittadini stranieri residenti regolarmente in Italia possono acquisirla per “ius soli” (diritto del suolo) o per matrimonio, rispettando specifici parametri. La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e i suoi regolamenti prevedono la residenza legale, continuativa e ininterrotta, capacità reddituale, conoscenza della lingua italiana e assenza di condanne penali o pericolosità sociale. Il referendum si limita a proporre la riduzione del requisito di residenza, lasciando invariati tutti gli altri parametri.
Rimborso delle Spese Referendarie: un altro nodo cruciale
Un’ulteriore motivazione per l’astensione strategica è quella di non permettere il rimborso delle spese per la campagna referendaria.
La legge 195/1974 e successive modifiche regolano i contributi pubblici ai partiti o movimenti politici, prevedendo rimborsi anche per le campagne dei referendum abrogativi (art. 75 Cost.) e costituzionali (art. 138 Cost.). In pratica, i comitati promotori possono ricevere un rimborso fino a un limite massimo di 2.582.285 euro annui, a condizione che la consultazione referendaria raggiunga il quorum di validità.
Contrariamente a quanto talvolta si percepisce, questa cifra, sebbene non irrisoria per il cittadino comune, ha un limite ben definito e non raggiunge gli “87 milioni” di cui alcuni utenti parlano. La cifra degli 88 milioni di euro (per l’esattezza) riguarda le stime ufficiali complessive che includono tutti i costi operativi legati ai seggi e alle votazioni. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un intervento del 5 giugno passato, ha stimato diversamente un costo ancora superiore, oltre i 400 milioni di euro, ma questa è una cifra quasi cinque volte superiore alle stime ufficiali complessive e quindi non trova un riscontro oggettivo.
Facciamo “i conti della serva”!. A questo punto è utile inserire questi numeri nel contesto della spesa pubblica italiana. I 2.582.285 euro di potenziale rimborso ai promotori, qualora si raggiunga il quorum, rappresentano solo lo 0,000282% della spesa pubblica complessiva stimata per il 2025 (circa 915,8 miliardi di euro). Per fare un paragone in termini di peso sul bilancio statale, le spese per le forniture belliche, secondo l’Osservatorio sulle spese militari italiane, ammontano a oltre 2,5 miliardi di euro, pari allo 0,273% della spesa pubblica, ovvero quasi 1000 volte di più del costo del rimborso referendario.
Altre Osservazioni: il peso delle etichette e le strategie di voto
Durante l’esperimento, è emersa un’osservazione curiosa: pur non avendo il nostro giornalista espresso alcuna preferenza politica o di voto, è stato frequentemente etichettato come “cittadino di sinistra che vota sì a tutti e cinque i quesiti”. Altri commenti hanno evidenziato la volontà di non votare per non “fare un favore alla CGIL” o, pur essendo sfavorevoli solo al quinto quesito (quello sulla cittadinanza), di astenersi completamente anche sui primi quattro quesiti per non “trainare” l’ultimo. Questo rivela come la percezione politica e le strategie di voto siano spesso complesse e stratificate.

Conclusioni: uno specchio della società digitale
Questo semplice esperimento sociale offre uno spaccato significativo delle aspettative, delle paure e delle motivazioni che animano gli italiani in vista del referendum. Dimostra anche il potere e l’influenza dei social media come strumento di dibattito pubblico, capace di generare reazioni forti e polarizzate anche in assenza di dati o evidenze oggettive.
La discussione è aperta, e le conclusioni, per ora, restano affidate alla riflessione di ciascuno. Quale messaggio arriverà dalle urne l’8 e 9 giugno? Il futuro prossimo ci darà le risposte.
Crediti immagini:
Voto_1_Quia_AI e Voto_2_Quia_AI di Quia Magazine © 2025 Riproduzione riservata – tutti i diritti riservati
Fonti per approfondire: