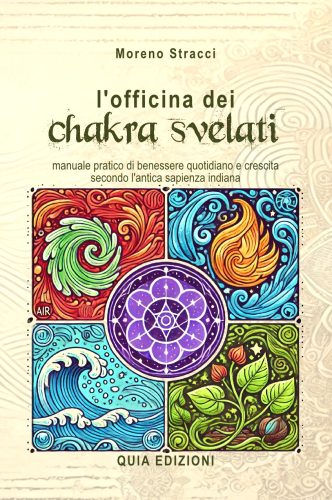Uomo e natura, un legame spezzato: lo studio dell’Università di Derby
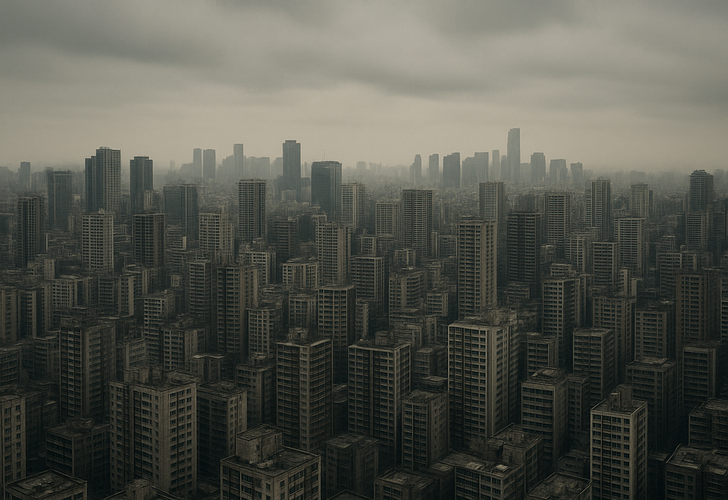
di Moreno Stracci
Uno studio dell’University of Derby mostra come il legame con l’ambiente naturale sia crollato dal 1800 a oggi, e cosa servirebbe per ricostruirlo.
Negli ultimi due secoli, la connessione tra esseri umani e natura si è ridotta di oltre il 60%. Lo rivela una ricerca pubblicata a luglio 2025 sulla rivista Earth da Miles Richardson, che ha utilizzato un sofisticato modello di simulazione “agent-based” – un approccio computazionale che ricrea il comportamento di individui o gruppi (“agenti”) e le loro interazioni con l’ambiente – per analizzare il periodo 1800–2020 e proiettare la tendenza fino al 2125. Lo studio evidenzia come urbanizzazione, perdita di biodiversità e minore trasmissione culturale di esperienze naturalistiche abbiano progressivamente eroso questo legame.
Un modello basato su dati storici e sociali
Per costruire la simulazione, i ricercatori hanno usato indicatori come la densità urbana, il numero di specie animali e vegetali presenti in un dato territorio e il tempo medio trascorso all’aperto dalle persone in diverse epoche. Ad esempio, nel 1800 oltre l’80% della popolazione europea viveva in contesti rurali, con contatti quotidiani con ambienti naturali. Oggi, nelle stesse aree, oltre il 75% vive in città e trascorre in media meno di un’ora al giorno in spazi verdi.
Il modello prevede che, senza interventi, entro il 2125 la connessione con la natura in alcune metropoli occidentali possa scendere a meno del 10% del livello registrato a inizio XIX secolo.
Il meccanismo del “punto di non ritorno”
Lo studio introduce un concetto chiave: il “tipping point” (punto di non ritorno) della disconnessione. Una volta che la quota di popolazione con bassa connessione alla natura supera il 60%, diventa estremamente difficile invertire il trend, anche con politiche ambientali mirate. L’esempio riportato è quello di Londra: tra il 1950 e il 2000, la riduzione di spazi verdi accessibili ha accelerato la perdita di interesse verso attività all’aperto nelle nuove generazioni, con un calo del 40% nelle visite ai parchi cittadini in meno di trent’anni.

Scenari futuri: tre possibili traiettorie
Lo studio ha modellato tre scenari principali:
• Business as usual: continuità con le politiche attuali, che porta entro il 2125 a una riduzione media globale della connessione con la natura a valori inferiori al 20% di quelli storici. Nello stesso scenario, in alcune grandi aree urbane occidentali, il valore scende ben al di sotto del 10%, segnando una disconnessione quasi totale. Il superamento del “tipping point” è previsto già intorno al 2050 in molte regioni, rendendo il recupero estremamente difficile.
• Scenario intermedio: interventi locali, come parchi urbani e programmi scolastici outdoor, che rallentano ma non fermano il declino, mantenendo la media globale attorno al 30% entro il 2125.
• Scenario trasformativo: ristrutturazione radicale degli spazi urbani con “green corridors”, obbligo di ore scolastiche all’aperto e protezione di habitat naturali. In questo scenario, la connessione potrebbe risalire fino a circa il 50% dei livelli storici già nel 2080.
Un esempio concreto viene dalla città di Singapore, dove la pianificazione urbana integrata con la biodiversità ha portato, negli ultimi vent’anni, a un aumento del 15% nella percezione di benessere associata alla natura tra i cittadini.
Implicazioni psicologiche e culturali
Gli autori sottolineano che la connessione con la natura non è solo un indicatore ambientale: è correlata al benessere mentale, al senso di comunità e alla disponibilità ad agire per l’ambiente. Lo dimostrano i dati raccolti su un campione di 1.200 persone in Regno Unito e Stati Uniti: chi ha un punteggio alto di “Nature Connectedness” riporta livelli più bassi di ansia e depressione e compie il doppio di azioni pro-ambientali rispetto a chi ha punteggi bassi.
Anche la cultura rispecchia questa tendenza: l’analisi di un corpus di testi letterari e giornalistici mostra una riduzione progressiva dei termini legati alla natura, come “bosco”, “prato” o “ruscello”, sostituiti da termini tecnologici o urbani.
Un appello urgente
Richardson conclude che “ripristinare la connessione con la natura è possibile, ma richiederà un’azione costante per decenni per invertire le tendenze culturali che l’hanno ridotta”. Ogni generazione che cresce con un forte legame con la natura diventa una generazione di custodi dell’ambiente; senza questo legame, la transizione ecologica diventa un obiettivo lontano e fragile.
Lo studio invita governi, scuole e comunità a trattare la connessione con la natura come una risorsa strategica, al pari dell’aria pulita o dell’acqua potabile.
Riflessione
La riflessione politica che lo studio stimola — e che si lega bene anche alle agende internazionali sull’ambiente come l’Agenda 2030 dell’ONU o il Green Deal europeo — è che le politiche ambientali non possono limitarsi alla dimensione normativa e tecnica. Il modello di Richardson mostra chiaramente che la variabile più lenta e determinante è l’orientamento culturale e affettivo verso la natura, trasmesso di generazione in generazione. Se questo rimane basso, anche le migliori politiche di tutela ecologica rischiano di avere un impatto limitato o temporaneo.
Per questo la politica dovrebbe integrare l’educazione ambientale in modo strutturale e continuativo nei programmi scolastici, coltivare esperienze dirette con la natura — soprattutto in ambito urbano —, rafforzare il ruolo delle comunità locali nella gestione di spazi verdi e progetti di rinaturalizzazione, e riportare la natura al centro dell’immaginario collettivo attraverso media, arte e letteratura. In altre parole, senza un cambiamento del cuore e della mente dei cittadini, il cambiamento delle leggi da solo non basta: le leggi sono fondamentali, ma devono essere accompagnate da una trasformazione culturale che renda la connessione con la natura parte integrante dell’identità sociale.
Lo studio di Richardson ci ricorda che la connessione con la natura è un processo culturale profondo. Se vogliamo davvero invertire il trend, dobbiamo lavorare non solo sulle nuove generazioni, ma anche sugli adulti che oggi modellano valori e comportamenti. L’educazione ambientale fuori dalla scuola può assumere forme diverse: programmi pubblici nelle città, percorsi esperienziali nei parchi, laboratori comunitari di biodiversità urbana, narrazioni che raccontino la natura come relazione e non come semplice risorsa da sfruttare.
E qui emerge un nodo cruciale: molti contatti con la natura oggi restano ancorati a una logica utilitaristica, in cui essa è un mezzo per il proprio equilibrio o relax, ma raramente diventa oggetto di reciprocità e custodia. Il cambiamento necessario è nella nostra mentalità: riconoscere la natura come parte integrante della nostra identità e cultura, e non come semplice strumento al servizio dell’individuo.
Leggi lo studio:
Richardson, M. (2025). Modelling Nature Connectedness Within Environmental Systems: Human-Nature Relationships from 1800 to 2020 and Beyond. Earth, 6(3), 82. https://doi.org/10.3390/earth6030082
Immagine di copertina Quia Magazine AI
Quia APS ©2025 tutti i diritti riservati