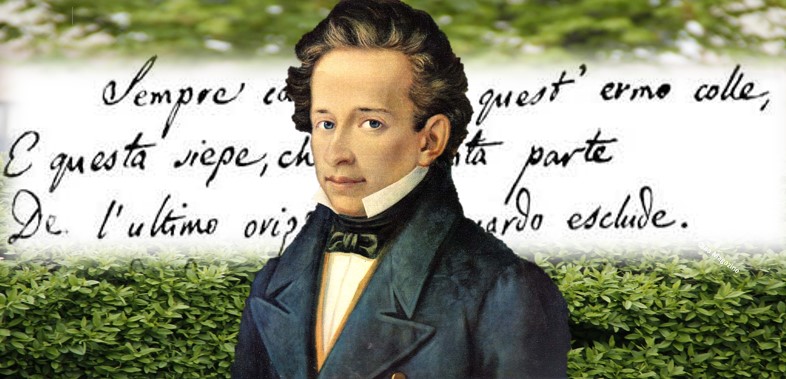W. S. Maugham: il narratore dell’inconscio

William Somerset Maugham, figura preminente nella letteratura del XX secolo, si distingue come prolifico romanziere, drammaturgo e autore di racconti il cui lavoro continua a catturare il pubblico con le sue profonde riflessioni sulla condizione umana. Nato il 25 gennaio 1874 a Parigi, la vita e la carriera di Maugham si svilupparono in un periodo tumultuoso della storia, testimoniando due guerre mondiali e la rapida trasformazione della società. La sua opera letteraria, contraddistinta da un’acuta osservazione del comportamento umano e uno stile narrativo accattivante, lo consolida tra i giganti letterari della sua epoca.
Orfano in giovane età, fu inviato a vivere con lo zio, un vicario. Nonostante le aspettative familiari, la passione di Maugham per la letteratura prevalse. Pur studiando medicina a Londra, coltivò le sue ambizioni letterarie senza cedimenti. La sua formazione scientifica fornì un terreno fertile per i suoi futuri lavori, infondendoli di una profonda comprensione delle complessità della psicologia umana e delle relazioni.

La carriera letteraria di Somerset Maugham è tradizionalmente divisa dalla critica in tre fasi:
Durante i primi anni, Maugham sperimentò con vari generi e stili, cercando di trovare la sua voce unica. Il suo primo romanzo, “Liza of Lambeth” (1897), ambientato nei quartieri della classe operaia di Londra, racconta di un adulterio e trae ispirazione dalle esperienze dirette dello scrittore quando, da studente di medicina, operava come ostetrico a Lambeth, quartiere degradato della città. Questo romanzo già mostra la sua capacità di raffigurare le sfumature della vita quotidiana. Il successo di quest’opera d’esordio fu un segnale dei futuri successi di Maugham. Tuttavia, è con la pubblicazione di “Of Human Bondage” (1915) (in italiano: Schiavo d’amore) che Maugham si affermò veramente come una forza letteraria con cui fare i conti. Questo romanzo semi-autobiografico, che traccia la vita di Philip Carey, mostrò la maestria di Maugham nell’esplorare le complessità della psiche umana e l’impatto delle esperienze personali sullo sviluppo di ognuno di noi. L’opera ricevette inizialmente aspre critiche. Il Il New York World definì l’ossessione del protagonista Philip Carey “la schiavitù sentimentale di un povero sciocco”. Intervenne a favore di Maugham l’influente critico e romanziere Theodore Dreiser che paragonò il romanzo a una sinfonia di Beethoven. Grazie alla recensione positiva di Dreisder, l’opera divenne una delle più celebri di Maugham e continuò a diffondersi nel mondo ristampa dopo ristampa. Oggi è considerata da molti il suo capolavoro. Altra opera famosa è The Magician (1908), un romanzo in cui il protagonista, il mago Oliver Haddo, tenta di creare la vita. Si tratta di un’opera caricaturale sulla figura di di Aleister Crowley, occultista e mago (oltre che pittore scrittore e filosofo) dell’epoca, fondatore dell’Ordine Ermetico della Golden Dawn, il quale accusò Maugham di plagio. Questo libro è importante per comprendere l’evoluzione della scrittura di Maugham. Lo stesso, dopo cinquanta anni dalla pubblicazione dichiarò che aveva quasi dimenticato di averlo scritto e rifiutò lo stile usato etichettandolo come “ampolloso ed enfatico”.
La fase intermedia della carriera di Maugham vide una serie di successi sia nella letteratura che nel teatro. Le sue commedie, come “The Circle” (1921) e “Our Betters” (1923), divennero successi al botteghino, consolidando la sua reputazione di drammaturgo amato dal pubblico. Caratterizzate da arguzia e satira sociale, godettero di immenso successo sia nel West End di Londra che a Broadway.

Allo stesso tempo, i suoi romanzi, tra cui “Cakes and Ale” (1930) e “The Razor’s Edge” (1944), continuarono a riscuotere consensi critici per le loro profonde analisi dei personaggi e la perspicace critica sociale. “The Moon and Sixpence” (1919), romanzo ispirato alla vita dell’artista Paul Gauguin, mostrò la capacità di Maugham di immergersi nelle menti di personaggi non convenzionali ed esplorare la tensione tra le norme sociali e i desideri individuali.
Gli ultimi anni della carriera di Maugham videro un cambiamento di prospettiva: da narrazioni esterne a riflessioni interne. I suoi scritti di viaggio, come “The Gentleman in the Parlour” (1930), rivelarono un nuovo interesse per la filosofia orientale e la spiritualità. Queste opere mostrarono la visione di Maugham sulla vita in evoluzione, andando oltre i confini della narrazione convenzionale per esplorare profonde domande esistenziali.
Il lascito letterario di Maugham non è solo definito dalla sua maestria narrativa, ma anche dalla sua acuta comprensione della condizione umana. I suoi personaggi, spesso alle prese con dilemmi morali e crisi esistenziali, riflettono le complessità degli individui nella vita reale. La profondità psicologica con cui ritrasse i suoi personaggi, come l’artista tormentato Charles Strickland in “The Moon and Sixpence”, rimane una testimonianza della sua capacità di penetrare nell’anima umana, scavando nelle profondità dell’inconscio.

Non si può discutere di Somerset Maugham senza riconoscere il suo stile narrativo distintivo. La sua prosa è contraddistinta da chiarezza, semplicità e uno sguardo attento ai dettagli. La capacità di Maugham di comunicare emozioni complesse e relazioni intricate con precisione lo distingue come maestro narratore. L’eleganza del suo linguaggio, unita a una capacità di catturare le sfumature dell’interazione umana, contribuisce all’attrazione senza tempo che le sue opere producono in chi le legge.
Nonostante i suoi successi letterari, Maugham affrontò critiche per la mancanza di moralismo evidente nei suoi lavori. Alcuni contemporanei lo accusarono di essere solo un cronista degli eventi, privo di una bussola morale. Tuttavia, un’analisi più approfondita rivela che la distanza di Maugham dai suoi personaggi era una scelta narrativa precisa che permetteva e ancora permette ai lettori di trarre le proprie conclusioni e impegnarsi in un percorso di introspezione e riconoscimento delle proprie vicende in quelle dei personaggi creati dallo scrittore.
La riflessione sulle norme sociali, sulla libertà personale e sulle conseguenze della non conformità ricorrono frequentemente nei suoi lavori, e questo riflette direttamente le sue stesse esperienze, convinzioni e orientamenti, come la sua sessualità aperta di cui lui stesso parlava apertamente, in un’epoca difficile per certi argomenti.
L’influenza di Somerset Maugham sulla letteratura si estende al di là delle pagine dei suoi libri. La sua influenza è evidente nelle opere di scrittori successivi, tra cui Graham Greene e Tennessee Williams, che ammiravano la sua capacità di dissezionare la psiche umana ed esplorare gli angoli più oscuri dell’esperienza umana.
Come con ogni figura letteraria, il lascito di Maugham è soggetto a interpretazioni in evoluzione. Mentre alcuni critici enfatizzano l’apparente semplicità delle sue narrazioni, altri approfondiscono la complessità sottostante e la profondità dei suoi personaggi e temi. Indipendentemente dalla prospettiva, c’è un consenso innegabile sul fatto che i contributi di Somerset Maugham alla letteratura siano significativi.
In conclusione, William Somerset Maugham rimane una figura imponente negli annali della letteratura del XX secolo. La sua capacità di fondere abilmente la narrazione con l’analisi psicologica, unita a uno stile narrativo distintivo, ha lasciato un’impronta indelebile sul paesaggio letterario. Dalle vivaci strade di Londra ai paesaggi esotici dell’Oriente, le opere di Maugham continuano a risuonare nei lettori, offrendo un’esplorazione senza tempo della condizione umana. Riflettendo sulla vita e sul lascito di Maugham, ci viene ricordato che il potere della letteratura risiede non solo nella sua capacità di intrattenere, ma anche nella sua capacità di illuminare le complessità dell’esperienza umana. Soprattutto in questo senso, le opere di Maugham hanno ancora molto da insegnarci e andrebbero lette o rilette così come molte opere del passato spesso marchiate come pesanti o sorpassate. Bisogna invece riscoprirle, mettendo da parte di tanto in tanto opere di scrittori contemporanei che, al contrario, hanno poco o niente da dire.
Moreno Stracci
© Riproduzione riservata